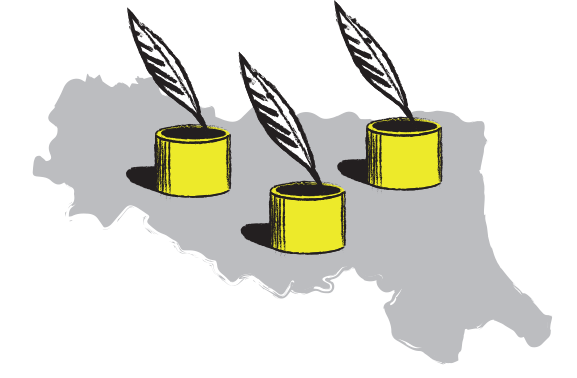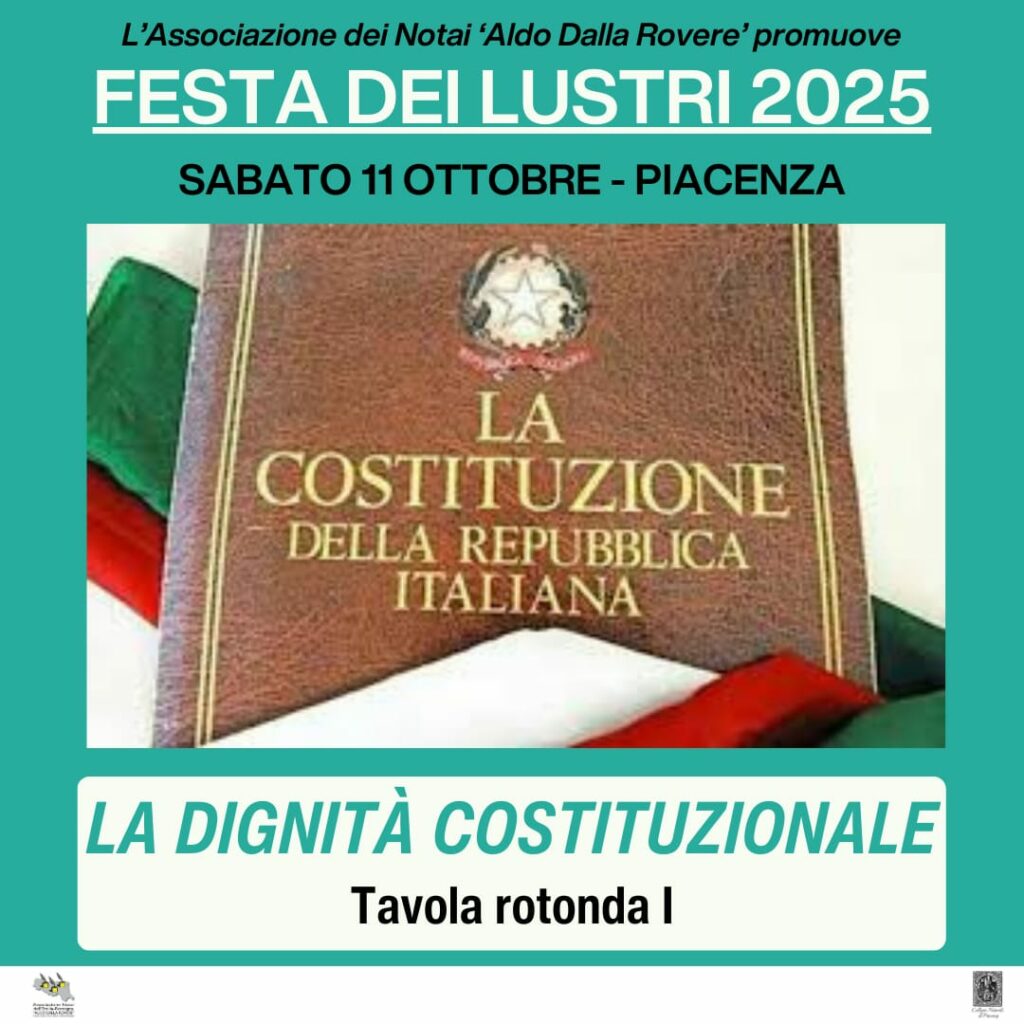LA DIGNITÀ DEL NOTAIO
LE TESI DELLA FESTA DEI LUSTRI
1. “LA DIGNITÀ COSTITUZIONALE”
Com’è noto, il Notariato è istituzione che risale ad epoca antecedente alla Costituzione Repubblicana, non è né un potere, né un organo costituzionale e neanche i notai sono menzionati nel testo scritto della Costituzione, diversamente da quanto accade sia per la Magistratura che per l’Avvocatura.
Ciò nonostante il notaio, che riunisce in sé la pubblica funzione e l’attività professionale è dentro la trama costituzionale, essendo la sua attività finalizzata a realizzare interessi ed assetti conformi all’ordinamento giuridico e quindi anche ai precetti costituzionali.
Un rinnovato interesse per l’argomento oggetto della tavola rotonda e per le problematiche connesse si ricollega a recenti istanze dell’Avvocatura, dirette ad ottenere il rafforzamento del ruolo dell’Avvocato in Costituzione, richiesta che sembrerebbe aver ricevuto l’apprezzamento del Ministro della Giustizia.
In particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha ipotizzato la modifica dell’art. 111 della Carta fondamentale, per riconoscere all’avvocato un ruolo pubblicistico, prevedendo la libertà e l’autonomia del professionista nonché la necessità inderogabile della difesa tecnica.
La promozione culturale ed intellettuale del notariato si riverbera inevitabilmente sulla sua struttura istituzionale, trasfigurandola nel profondo, formalmente e sostanzialmente, fino a caratterizzarne le competenze: il notaio è il dominus esclusivo cui spetta il potere di indagare la volontà delle parti (art. 47 L.N.) e di curarne, quindi, la formulazione attraverso un’iniziale opera maieutica (originata nell’esternazione orientata) che sviluppa in un progressivo consolidamento verso la traduzione in modelli tipici precostituiti dalla legge, di cui diventa il depositario.
Il dibattito che si vuole aprire nella tavola rotonda è diretto a meglio definire l’attuale ruolo del notaio.
La finalità è dunque quella di veicolare, anche all’esterno della categoria, l’immagine non solo di un documentatore-certificatore, ma di un interprete attento, che svolge una funzione, sicuramente valorizzata da numerosi interventi del legislatore.
Francesco Carnelutti concepiva il notaio come “custode o guardiano del diritto”. La sua opinione, maturata già nella prima metà del ‘900, esaltava il ruolo pubblicistico del notaio ed è stata accolta e sviluppata da insigni giuristi: Mario Nigro ha definito il notaio “Ufficio della Repubblica non inquadrabile nel sistema della Pubblica Amministrazione”.
La libera professione non intacca la funzione pubblica, ma è solo il modo con cui la stessa viene esercitata.
Sono tratti peculiari il meccanismo di selezione e l’accesso mediante concorso pubblico, la delega dello Stato e la speciale efficacia probatoria degli atti redatti, l’incompatibilità, un sistema di rigorosi controlli pubblici, la doverosità e la neutralità della funzione, la terzietà, il controllo di legalità e la funzione di garanzia.
In conclusione, il notaio è a disposizione della collettività e, da giurista, applica il diritto e garantisce che l’applicazione sia uguale per tutti, il che rimanda al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Evidente è il riferimento all’art. 41, che regola la libertà di iniziativa economica, all’art. 18 che sancisce la libertà di associazione, all’art. 29 che disciplina la tutela della famiglia.
Il notaio entra a pieno titolo nel “sistema Giustizia”, visto che concorre a realizzare la tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione): assicura una tutela preventiva, che certamente concorre a ridurre il contenzioso, concetto espresso dalla celebre espressione di Carnelutti “tanto più notaio, tanto meno giudice”.
DOMANDE
Non lasciamoci sfuggire questa occasione! Il legame fra NOTAIO e COSTITUZIONE è nel testo di diversi articoli della Carta, della L.N. e di altre norme, ma non è esplicitamente riconosciuta la nostra funzione nella cosiddetta “Costituzione formale”. Ritieni che il Consiglio Nazionale debba adoperarsi per una riforma della Costituzione che riconosca la nostra funzione?
- Sì, è giunto il momento che lo Stato che noi serviamo quotidianamente ci riconosca come sua articolazione di rango costituzionale. Ne va della nostra dignità, presente e futura, perché siamo pubblici ufficiali.
- No, Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, ha individuato il potere legislativo, esecutivo e giudiziario e non anche quello notarile.
- Sì, il riconoscimento della funzione notarile, che si esplica a diversi livelli costituzionali (protezione della proprietà privata, sviluppo dell’iniziativa economica, successioni mortis causa, tutela dell’associazionismo, liquidazione e riscossione di tributi, partecipazione alla giurisdizione con le competenze di VG e la prevenzione del contenzioso, tutela della sicurezza dei pubblici registri, …), deve passare dall’espresso riconoscimento nella Carta Costituzionale, in modo che la nostra categoria riceva una tutela più coerente alla funzione, allontanando il rischio che il potere politico, con intenti populistici, possa ritentare di eliminarci.
- No, non ce n’è alcun bisogno: siamo già pienamente riconosciuti dallo Stato e riceviamo sempre più attribuzioni di competenze e responsabilità (e ciò è chiaro indice della nostra indispensabilità funzionale).
Il mondo evolve con grande rapidità ed una nuova modulazione tra funzioni pubbliche e private (nei settori dell’edilizia, antiriciclaggio, economia per citarne solo alcuni) ha trovato nel Notariato un tessuto fertile e grande disponibilità a sinergie con altri Organi dello Stato. Al di là del riconoscimento esplicito nella Costituzione formale (per inciso, gli avvocati lo stanno facendo) riflettiamo insieme, cercando innanzitutto di ridefinire la nostra immagine e valorizzare il nostro ruolo, dai forti connotati pubblicistici?
- No, proprio perché sono già ben note le capacità e le disponibilità del notariato, dobbiamo fortemente solo insistere perché di presenti un DDL di modifica costituzionale.
- Sì, è una attività che è necessaria e va fatta per il bene di tutti i Notai: la categoria è ampia e segnata da diverse consapevolezze di sé. Approfondire i connotati pubblicistici e le responsabilità legate alla funzione notarile non può che giovare alla salute interna del Notariato.
- No, abbiamo vinto il concorso, abbiamo fatto tirocinio, siamo già pubblici ufficiali e ciò è ben noto a tutti; e nel caso qualche collega lo dimenticasse, allora dovrebbe intervenire la disciplina deontologica, se non anche in quella della Procura della Repubblica.
- Sì, riflettere sulla nostra natura per ridefinire, con studi dedicati, come le competenze notarili si siano ampliate negli ultimi anni e, quindi, come il Notariato sta rispondendo ai bisogni del Paese con spirito di servizio allo Stato, è importante sia per una formazione interna che per procedere alla predisposizione di un DDL costituzionale che recepisca formalmente questa nostra natura.
Non è già un risultato positivo che verso la nostra categoria sia emerso un certo favor, che ha diluito il clima avvelenato di alcuni fa? Non credete che sia un bel risultato esser riusciti a reagire ai preconcetti con grande sensibilità istituzionale, evitando anche il rischio di cadere in una crisi d’identità?
- Sì, questo però è solo un primo traguardo di riconoscimento di cosa il Notariato può e vuole dare al Paese; dobbiamo raggiungere il secondo traguardo del riconoscimento in Costituzione perché il favor attuale si solidifichi contro un futuro più oscuro.
- Sì, questo è proprio il segnale forte che lo Stato già ci riconosce come un interlocutore privilegiato e ciò basta, anche perché l’eventuale menzione in Costituzione porterebbe con sé altre responsabilità
- No, è solo la dimostrazione che se non otteniamo un riconoscimento della nostra funzione all’interno della Carta costituzionale, il Governo di turno ci sfrutta oppure ci butta via.
- No, non è un bel segnale perché è solo un aumento di responsabilità che lo Stato ci dà senza che in cambio riceviamo nulla.
2. LA DIGNITA' DELLA PENSIONE
In arrivo il 22 Settembre
Retributivo, contributivo, misto, patrimonio, erogazioni, aggiornamenti, integrativa, salute:
quale direzione?
Come sappiamo, il sistema pensionistico del Notariato è basato su un principio mutualistico puro, che quindi prescinde dai contributi versati da ognuno di noi e tiene conto unicamente dell’anzianità di servizio; ciò in quanto siamo vincitori di un concorso pubblico, obbligati a svolgere una pubblica funzione nella sede che ci viene assegnata (e nei territori limitrofi), indipendentemente dalla nostra capacita reddituale e quindi senza tenere conto del fatto che siamo al contempo anche liberi professionisti.
Questo sistema non è mai stato messo in discussione, né ha mai creato problemi sugli equilibri finanziari delle nostra Cassa di Previdenza fino all’avvento delle lenzuolate di Bersani, che hanno comportato l’abolizione delle tariffe, cui ha fatto seguito la messa a regime degli uffici secondari, che ha profondamente mutato il rapporto tra Notaio e territorio, creando problemi di gestione nella nostra Cassa, anche a seguito di molte richieste di pensionamenti anticipati.
Nonostante le continue affermazioni dei Consiglieri dalla Cassa del Notariato sulla solidità del nostro sistema previdenziale, è da diversi anni che tra i componenti dell’Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato c’è preoccupazione per il mancato adeguamento delle pensioni, il che ha portato – da ultimo – l’Associazione Nazionale Notai in pensione a promuovere una causa contro la Cassa per la perequazione delle pensioni, motivandola, tra le altre – con la causale che non sia stato perseguito lo scopo della Cassa Nazionale del Notariato, “istituita per garantire un’equa pensione ai propri iscritti, a favore di una patrimonializzazione non richiesta da ragioni di equilibrio, […] nella prospettiva di mantenere il nostro sistema solidaristico, ma con una pensione adeguata alle esigenze di una vita dignitosa per la quale la Categoria versa e ha versato contributi di rilevante entità”.
E’ evidente che il mancato adeguamento delle pensioni non riguarda solo i Notai in pensione, ma soprattutto quelli in esercizio, per i quali, nonostante i contributi versati, la Cassa di fatto riduce le future pensioni.
A questo punto il dubbio che molti di noi si pongono è se non sia opportuno apportare delle modifiche al sistema solidaristico, optando verso un sistema contributivo, oppure verso una contribuzione progressiva crescente al crescere dei volumi repertoriali, ferma una quota minima mutualistica.
Sarebbe comunque interessante – se non adottare un sistema pensionistico simile a quello degli altri professionisti italiani – almeno esaminare i motivi ispiratori degli altri sistemi previdenziali.
In un contesto in continua evoluzione, sia dal punto di vista normativo che tecnologico e sociale, è fondamentale che il Notariato sappia difendere ed affermare il proprio ruolo di pubblico ufficiale, garante della legalità e della certezza dei rapporti giuridici, nonché interlocutore affidabile delle istituzioni, purché sappia raccontarsi in modo nuovo, anche nel proprio interno, pur rimando fedele ai principi fondanti.
DOMANDE
Quanti anni servono per maturare il massimo della pensione?
- 30
- 35
- 40
- 25
E’ conciliabile un sistema pensionistico contributivo con la funzione pubblica del Notaio?
- NO, perché è applicabile solo ai liberi professionisti e non ai Pubblici Ufficiali
- SI’, ma solo come sistema misto contributivo/mutualistico
- SI’, perché le condizioni che hanno ispirato il nostro sistema previdenziale sono da ritenersi non più adeguate alle esigenze della società attuale
- NO, perché lo Statuto della nostra Cassa di Previdenza non lo consente
E’ legittima la norma del regolamento previdenziale della Cassa che limita l’adeguamento delle pensioni?
- SI’, perché garantisce la stabilità del sistema
- NO, perché non tiene conto dell’esigenza di garantire un’equa pensione ai propri iscritti
- NO, perché penalizza soprattutto i giovani Colleghi, destinati a percepire pensioni di fatto sempre più inadeguate al costo della vita
- SI’, perché non ci sono altri sistemi per bilanciare le esigenze di patrimonializzazione della Cassa
Possiamo trarre ispirazione dalle regole di altri sistemi previdenziali per modificare il nostro?
- NO, perché siamo Pubblici Ufficiali e non liberi professionisti
- SI’, perché siamo anche liberi professionisti e non solo Pubblici Ufficiali
- NO, perché le norme istitutive della nostra Cassa non lo consentono
- SI’, perché le regole di carattere economico ci richiedono un confronto sul tema
3. LA DIGNITA' DEL COMPENSO EQUO
TAVOLA ROTONDA III
LA DIGNITA’ DEL COMPENSO EQUO.
Tariffa, equo compenso, compenso equo, proporzionalità, dignità: può ancora andarsi
avanti così?
L’art. 36 della Costituzione prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Tale norma prevede anche che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla
legge e che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e che non
può rinunziarvi.
La norma è dettata pensando al lavoratore subordinato, come del resto appare
immediatamente alla lettura dei commi successivi al primo, ma pone un principio che forse
abbiamo dimenticato o forse non riusciamo a sentire davvero nostro.
Ogni lavoro merita di essere remunerato, anche il nostro, e merita di esserlo in
proporzione: proporzione che non può non essere predeterminata in maniera oggettiva.
Gli anni passati hanno dimostrato che i compensi si sono abbassati inesorabilmente e
progressivamente, a fronte di costi di gestione solamente aumentati.
Il costo di un atto va necessariamente valutato sommando questi addendi: il tempo che gli
dedichiamo personalmente; il costo dei dipendenti; il costo del software; il costo
dell’hardware; spesso, il canone di affitto dello studio; i costi delle utenze; l’assicurazione
professionale obbligatoria; la cancelleria; la rilegatura; eventuali sanzioni dell’Archivio
notarile; il costo della formazione affrontato per vincere il concorso; il costo della
formazione affrontato per i crediti formativi obbligatori; il costo della franchigia se un
domani avremo un sinistro.
Gli addendi sopra indicati valgono per tutte le professioni intellettuali, tralasciando il fatto
che il nostro lavoro, in concreto, è l’unico che presuppone indefettibilmente una struttura.
Ma c’è di più.
La nostra Categoria presenta svariate peculiarità rispetto alle altre professioni che
dovrebbero far comprendere come l’assenza di un compenso inderogabile sia una anomalia
incompatibile con l’esistenza stessa del Notariato.
La personalità della prestazione. Qualunque professione può consentire una delega ed un
decentramento tali da consentire al “dominus” di basarsi esclusivamente sulla sua capacità
organizzativa e sui contatti creati (o ereditati), arrivando quasi ad azzerare il suo apporto
personale in termini di tempo lavorativo, cosa incompatibile col Notaio che, se assente,
ferma la “macchina”: se quasi qualunque lavoratore apicale può creare la marginalità (e
ridurla quasi a zero inseguendo l’economia di scala) ottimizzando la struttura, il Notaio che
rispetta le norme impiega necessariamente il proprio tempo.
Il controllo di legalità. Il Notaio deve necessariamente rispettare e far rispettare la legge in
termini stretti, per cui poche professioni vedono come leva concorrenziale la compiacenza.
Il Notaio è un Giudice ex ante non stipendiato e può espletare il proprio ministero alla
lettera solo in un sistema dove può togliersi dall’equazione concorrenziale almeno la misura
del compenso.
La sostenibilità economica ed il servizio pubblico. Qualunque operatore economico è
ontologicamente libero di fallire e di “chiudere i battenti” qualora non faccia bene i conti,
non si posizioni adeguatamente nel mercato o non riesca più a risalire la china instaurata dal
sistematico dumping dei prezzi (delle tariffe).
Il Notaio deve garantire il presidio della sede e l’accesso del cittadino alla sua prestazione,
per cui non è libero di “vendere” la propria prestazione sotto il costo di produzione.
La delega di funzioni e l’assimilazione con la Pubblica Amministrazione. Ogni Pubblica
Amministrazione applica dei costi fissi in sede di erogazione dei servizi e delle prestazioni
parametrati al valore ragionevole sostenibile dal cittadino ed al costo della struttura che lo
eroga.
Se ogni imposta dovuta per la registrazione di un atto di valore proporzionale ha dei valori
minimi ineludibili, non si vede perché ciò non debba accadere anche per una prestazione
erogata su delega dello Stato e nell’interesse di questo, laddove la delega implica che tale
prestazione non sia gestibile in autonomia da parte della Pubblica Amministrazione.
Il sistema previdenziale e gli onorari repertoriali. Non è più sostenibile versare contributi
parametrati su valori a prescindere dalla loro percezione dal cittadino.
Se vi è un onorario repertoriale, il Notaio non può essere normativamente libero di non
percepire neanche quello.
La conservazione. Ogni nostro atto conservato ha un costo di “locazione” ineludibile degli
spazi a nostra disposizione ed inoltre la conservazione è un lusso che andrebbe ricordato più
spesso al cittadino ed alle Istituzioni. Da noi ogni cosa si troverà sempre.
La certezza per il cittadino. Poichè la legge prevede per il cittadino l’obbligo di avvalersi
della prestazione professionale del Notaio, non è possibile accettare che non ci siano limiti
anche verso l’alto per le prestazioni ordinarie: per traslato, se non è accettabile che vi siano
limiti massimi, nessun sistema può applicare questi senza applicare al contempo limiti
minimi.
La reintroduzione di compensi professionali minimi è a presidio anche dell’immagine della
Categoria e delle professioni intellettuali tutte, così come dell’educazione della società
civile in senso generale.
Il cittadino è disorientato perché non sa più quale è il costo ragionevole di un atto e di una
prestazione professionale.
Mentre nel settore della produzione spesso vi è un collegamento istintivo alla qualità in caso
di spesa elevata (od allo status di chi si può permettere una certa spesa), nel settore
professionale il cittadino medio non ipotizza che il professionista a buon mercato sia
scadente o che dedicherà meno tempo alla pratica a fronte di una bassa remunerazione.
Altro aspetto che potenzialmente verrebbe ad essere tutelato/implementato da compensi
minimi inderogabili è correlato alla qualità della prestazione.
La costante riduzione della remunerazione ci ha portato a diventare dei cottimisti e dei
massificatori di pratiche.
Un tempo la sostenibilità veniva raggiunta con meno atti e quindi si poteva dedicare molto
più tempo personale ad una pratica in quanto adeguatamente remunerato: ora dedicare
molto tempo ad una posizione ed allo stesso cliente è diventato un lusso che ci si può
permettere fino ad un certo punto.
La modulazione del lavoro. Ad essere onesti, rimane indubitabile che ognuno di noi ha
appetiti variegati ed aspettative diverse dalla professione.
L’assenza di compensi minimi inderogabili costringe anche chi si accontenterebbe di regimi
lavorativi “bassi” ad inseguire gli incarichi oltre le possibilità di tenuta della propria struttura
organizzativa, laddove ci vogliono ormai molti atti per avere margini di sostentamento dei
dipendenti e di se stessi.
Con compensi minimi inderogabili le occasioni per Notai aventi inclinazioni opposte (il maxi
stipulatore e l’artigiano) di scontrarsi sullo stesso cliente sarebbero quasi ridotte a zero.
I compensi minimi inderogabili che dovremmo avere e che abbiamo implicitamente in
mente inciderebbero sul valore generale delle transazioni in un rapporto percentuale più
che sostenibile e che, visto con onestà intellettuale da parte dei cittadini e delle Istituzioni,
sarebbe ben poca cosa.
Potrebbe anche ipotizzarsi secondo alcuni, vista la terzietà del Notaio, l’applicazione del
compenso a carico di tutte le Parti dell’atto.
Un Paese civile non può ammettere l’assenza di compensi minimi inderogabili e noi siamo in
un Paese che ci obbliga a non percepire compenso per le SRLS.
Forse abbiamo detto tutto.
Questa non è dignità.
Prima ancora per l’Italia che per noi che vi abbiamo supinamente abdicato.
4. LA DIGNITA' DELL'INTELLIGENZA (ARTIFICIALE)
In arrivo il 6 ottobre
Tavola rotonda QUATTRO
La dignità dell’intelligenza (artificiale)
Allucinazioni, bias, disallineamenti: il notariato è presidio di verità
Documento
L’intelligenza, quella aumentata, per non dire artificiale, non è più la frontiera, ma è la quotidianità. La “nostra” Notartel sforna tante novità e sappiamo che ci sta lavorando, ma cosa sta facendo? Quali sono gli obiettivi che sta perseguendo in materia di IA?
L’architettura sociale a cui siamo abituati sta cambiando. E il cambiamento sta avvenendo in tempi rapidissimi che l’esperienza storica collettiva, cioè l’abilità nel riconoscere per adattarsi ai cambiamenti, non riesce a quasi a percepire.
Non abbiamo un’esperienza che sia assimilabile a quanto sta avvenendo e questa mancanza non aiuta né facilita il naturale adattamento.
Dal 2023, anno del lancio della prima versione diffusa di ChatGPT, stiamo vivendo un tempo più che accelerato. Tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a confortarci con qualcosa di nuovo e che si fatica a comprendere se non se ne approfondisce il contesto.
Ma la novità sono solo i Chatbot e, ancor più recenti, gli agenti IA; si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale nel 1956e da anni, seppur non proprio consapevolmente, la utilizziamo quando compriamo online un viaggio, acquistiamo su Amazon, o prenotiamo un tavolo per la cena.
Nel 2015 Roberto Calderoli presento 82.730.460 emendamenti generati con un algoritmo, tutti lavorati con l’applicazione di un altro algoritmo. In ambito scientifico si usano algoritmi per la ricerca da decine d’anni. Ma con il 2023 tutto è cambiato e già si è delineata una contrapposizione.
Da una parte, coloro che comprendono l’ormai ineluttabile presenza degli algoritmi: con senso critico ne vogliono capire l’utilizzo e i benefici che da questo ne possono derivare, tanto alla propria attività (ambito individuale), quanto alla crescita del benessere collettivo (ambito sovraindividuale).
Sono questi i soggetti che culturalmente sono educati alla ricerca, alla curiosità, al dubbio intellettuale, indipendentemente dal settore di attività occupato, e, contemporaneamente, ne hanno anche la disponibilità economica.
Dall’altra parte vi è una massa ben più grande, costituita da coloro che (ancora) a tutto ciò non si sono approcciati. E’ questa una ampia e generica categoria composta a sua volta da sottogruppi.
Ci sono coloro che non vogliono nemmeno avvicinarsi ai più accessibili chatbot per una sorta di opposizione ideologica.
Vi è chi, pur incuriosito, non può farlo per mancanza della relativa disponibilità economica. Di maggior rilievo (e altrettanta preoccupazione) è la massa di coloro che, pur avendone l’accesso, anziché disporre di tali strumenti volendone gli effetti, li subiscono passivamente e acriticamente a causa della loro pigrizia intellettuale che li caratterizza.
Dove si colloca il notariato?
Per sua natura istituzionale e intellettuale, il notariato svolge una funzione di pubblica utilità per la sicurezza giuridica dei traffici economici ritenuti più importanti e nella formazione di atti di particolare interesse delle persone, sia della sfera privata (atti mortis causa, amministrazione di sostegno, volontaria giurisdizione…) che della sfera di manifestazione della persona nelle collettività (atti associativi).
Il notariato, quindi, è una istituzione atta a supportare la collettività nell’interesse comune dello Stato a cui appartiene e, attraverso i rapporti internazionali, nell’interesse di tutti gli Stati dove il commercio e gli interessi individuali si sviluppano.
Il Notariato non può rimanere assente o, comunque, indietro in questo medioevo di trasformazione.
La velocità del cambiamento è misurata, non in decenni e neanche in anni, ma in mesi.
È stato calcolato che nell’arco di circa cinque anni sarà esistente l’Agi che porterà un ulteriore nuova evoluzione alla struttura della società.
È necessario che nei nodi strategici e rilevanti della struttura sociale, gli algoritmi e le loro applicazioni siano sotto il pieno controllo umano, in modo che la crescita del benessere collettivo continui positivamente; in particolare, per quanto ci riguarda:
– è necessario che il Notariato continui a presidiare la formazione di determinati tipi contrattuali e atti giuridici che l’ordinamento riconosce di significativa importanza sociale;
– è necessario che il notariato abbia la capacità tecnica per continuare a consentire che le persone possano manifestare consapevolmente la loro volontà negoziale;
– è necessario che il notariato si adatti nel minor tempo possibile, includendo nelle procedure l’utilizzo dell’IA e gestendo in modo consapevole l’evoluzione in corso.
Si sta qui facendo riferimento non alla gestione amministrativa dello studio, che è attività comune all’esercizio di ogni altra attività economica, che sia professionale, imprenditoriale, lucrativa o non lucrativa, ma si sta facendo riferimento all’esercizio della funzione notarile stessa, alla traduzione in uno strumento giuridico idoneo a realizzare la volontà delle parti.
Dall’utilizzo delle tecnologie IA, al Notariato potrebbe derivare una rinvigorita capacità di esercizio della funzione con ricadute di vantaggio per la collettività: la gestione e l’analisi dei dati che quotidianamente i Notai raccolgono e conservano, sono un patrimonio davvero di inestimabile valore, con il quale “allenare” algoritmi proprietari e fornire output in ambito immobiliare e societario che nessun’altra istituzione avrebbe con la stessa immediatezza.
È questa la fase dove ci collochiamo ed è questa la fase in cui è altamente pericoloso rimanere a guardare per l’impossibilità di determinare, non solo il futuro in sé, ma l’immediato domani del settore dell’intelligenza generativa applicata all’analisi dei dati giuridici tra i quali, per nostro interesse, i dati giuridici che emergono quotidianamente nei nostri oltre 5000 studi notarili.
Sono dati che noi raccogliamo, organizziamo in atti e possediamo. Sono dati che poi, in modo aggregato, versiamo allo Stato, proprietario dell’atto stesso. Sono dati che ci vengono affidati dai loro singoli proprietari: i cittadini. Abbiamo in mano un patrimonio enorme ma che con poca fatica si può essere tolto di mano.
DOMANDE
PRIMA
In che anno è nata l’intelligenza artificiale?
– 1879
– 1913
– 1956
– 2023
SECONDA
Oggi è possibile che un modello di linguaggio sia in grado di generare un atto giuridico?
– Sì, la magistratura adotta l’IA già in modo diffuso in tutti i gradi di giudizio tranne che in Cassazione.
– Sì, ma solo per contratti privati per i quali non sia necessario l’intervento del notaio
– No, gli atti che oggi possono essere generati devono necessariamente essere controllati da un professionista perché non vi è ancora un addestramento nè un allineamento che sia idoneo ad evitare allucinazioni e bais
– No, perché i Large Language Model (LLM) non possono essere in grado (ancora) di riconoscere la volontà delle parti
TERZA
È immaginabile e possibile che Notartel addestri uno Short Language Model (SLM) con i dati derivanti dagli atti notarili, dalla dottrina italiana civilistica amministrativa tributaria commercialisti e relativa giurisprudenza?
– No, è una attività che è vietata a Notartel perché è soggetto privato
– Sì, ma ormai è tardi perché è una attività che è già stata sviluppata dalle software house insieme alla Pa
– Sì, è possibile che Notartel alleni una IA proprietaria con i dati indicati, in modo da fornire ai Notai italiani il primo strumento dedicato di settore
QUARTA
L’attività di raccolta dei dati statistici può essere migliorata da una applicazione IA da inserire nei software di studio che invii a Notartel e, quindi, al CNN, i dati delle transazioni che vengono effettuate negli studi notarili? È un’attività che potrebbe portare ad un vantaggio per il notariato?
– No, sarebbe solo un ulteriore inutile spesa a carico di Notartel e, quindi, delle nostre tasche. Il Notaio esiste indipendentemente da queste attività che, si sa, sono destinate a ridursi nei prossimo futuro.
– No, sarebbe solo un nuovo progetto, di sicuro interesse e fascino, ma un’analisi così puntuale del mercato immobiliare e dell’evoluzione delle società commerciali italiane fornirebbe dati che non porterebbero direttamente alla categoria un riscontro economico e un vantaggio concreto, perché il sistema in cui il notariato è inserito di intermediazione non è sicuramente modificabile dal solo notariato
– Sì, una raccolta di dati di questo tipo e la loro analisi effettuata in tempo zero da algoritmi a ciò dedicati, sviluppando il settore già reso efficiente dell’analisi dei dati statistici, darebbe al notariato la proprietà di un set enorme di informazioni, quotidianamente puntuale, da poter sviluppare una modifica del sistema attuale di informazione commerciale, non disponibile ad altrimenti.
APPUNTI
L’intelligenza artificiale, come disciplina scientifica, è nata ufficialmente nel 1956, durante la conferenza di Dartmouth. In questa occasione, il termine “intelligenza artificiale” fu coniato da John McCarthy, che insieme ad altri scienziati come Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathan Rochester, definì questa nuova area di studio come la “scienza e l’ingegneria di creare macchine intelligenti”.
Tuttavia, le radici dell’IA possono essere rintracciate anche in lavori precedenti, come l’articolo “Computing Machinery and Intelligence” di Alan Turing nel 1950, dove veniva introdotto il concetto del Test di Turing per valutare l’intelligenza delle macchine.
In sintesi, mentre i concetti e le prime riflessioni sull’IA risalgono agli anni ’50, la data ufficiale di nascita della disciplina è considerata la conferenza di Dartmouth del 1956.